Per fornire al nostro lettore un quadro d’insieme, quanto più esaustivo possibile, si elencano di seguito, per parole chiave, gli elementi fondanti e annotazioni circa le nuove tendenze compositive dello haiku:
- Kigo, kidai, piccolo kigo: termine stagionale (kigo), tema stagionale (kidai). Ovvero, ciò che contestualizza in maniera esplicita o indiretta il periodo dell’anno in cui l’haiku viene composto. In Giappone esiste il saijiki(ampia raccolta di kigo classificati secondo le quattro stagioni) da cui poter attingere. Deve essere ben chiaro, però, che la necessità di indicare il ciclo temporale all’interno dell’haiku vada sempre intesa nei dettami della filosofia Zen: del qui e dell’adesso; dell’hic et nunc d’afflato heideggeriano (se vogliamo trovare uno spunto filosofico occidentale). L’haijin, necessariamente, non può non restare in contatto con la propria temporalità divenendo un tutt’uno (kikan) con la Natura circostante. Secondo Masaoka Shiki gli haiku sono dei piccoli quadri che fissano un’istante di vita quotidiana (shasei). Nella composizione di un haiku, bisogna non dire e non dimostrare nulla ma suggerire e mostrare, lasciando che sia la mente e la sensibilità del lettore a cogliere e sondare stati d’animo e connesse profondità; quell’equilibrio tra la costanza e il mutamento di cui, quotidianamente, facciamo esperienza. Nella modernità è stato inserito anche il concetto di piccolo kigo (es. alba, tramonto) dettato, pertanto, da un momento specifico della giornata. Un’ultima notazione: in Giappone, l’haiku sprovvisto di riferimento stagionale, viene chiamato mukigo (mu=senza; kigo= stagione) e spesso collima con un altro tipo di componimento nipponico detto senryū.
- Il metro: canonici tre versi (ku) con schema classico 5/7/5: 5 more (on) nel primo verso (kamigo); 7 nel secondo (nakashichi) e nuovamente 5 nel terzo (shimogo). Tre versi con metro moderno: 17 more complessive nei tre kucon distribuzione arbitraria. Ci sono altre scuole, anche giapponesi, dove il numero di on presenti può essere anche superiore o inferiore a 17.
- Toriawase:il termine indica l’accostamento d’immagini. È peculiare, nello haiku, il collegamento di due immagini distinte. Tale legame può essere prodotto in maniera armonica (torihayasi) conferendo un senso di continuità nei tre ku oppure per ribaltamento scenico (nibutsu sougheki) ovvero sia, creando un gioco di contrasto con l’immagine iniziale proposta. La toriawase, però, può anche non essere presente lasciando che l’haiku sviluppi sui suoi tre versi una sola immagine/argomento.
- Kireji: in Giappone, il termine indica “la parola che taglia”. È costituito da termini speciali non traducibili quali ya,kana e keri. Tali parole generano un effetto fonetico che consente il ribaltamento o l’armonizzazione della Nell’haiku internazionale ciò è espresso mediante segni d’interpunzione (es.: – , ; : .) I kireji, generalmente, vengono posti alla fine del primo verso o alla fine del secondo per indicare visivamente (nella fattispecie dell’haiku internazionale) che si sta per attuare l’accostamento. Se la cesura avviene all’interno del verso si chiamerà chukangire.
- Fūryū: il cammino di ricerca artistico-esistenziale da compiere in tre gradi tradizionalmente identificati nel rizoku, tanbi, shizenche consentiranno all’haijin di raggiungere l’illuminazione (satori): il risveglio spirituale nella pratica del Buddismo Zen. Dal fūryū derivano diverse forme estetiche conosciute come sabi, hanayaka, hosomi, futoi, ogosoka, okashii, wabi, shiori, kurai, makoto, yūbi, sōrei, gōka, yūgen, (mono no aware) aware, karumi, sabishisa, futoi.
Mirko Morello G.C.
Libri consigliati
- VV., Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, P. Lagazzi (a cura di), BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 1996;
- VV., Haiku. Il fiore della poesia giapponese da Bashō all’Ottocento, E. Dal Pra (a cura di), Mondadori, 1998;
- VV., Cento haiku, I. Iarocci (a cura di), Guanda, 2017;
- VV., Il grande libro degli haiku, I. Starace (a cura di), Castelvecchi, 2018;
- Akutagawa, Haiku e scritti scelti, La Vita Felice, 2013;
- Bashō, Poesie. Haiku e scritti poetici, La Vita Felice, 1997;
- Bonnefoy, Sull’haiku, O Barra O Edizioni, 2015;
- Heidegger, Sein und Zeit (Essere e Tempo), Halle, Germania, prima edizione 1927;
- Kerouac, Il libro degli haiku, Mondadori, 2003;
- Shiki, Bashō Zōdan. Bashō in frammenti, La Vita Felice, 2017;
- Shūzō, Sul vento che scorre. Per una filosofia dello haiku (Una riflessione sulfūryū), Il Nuovo Melangolo, 2012.
Articoli web utili
- VV., La poetica di M. Bashō come modello di riferimento, in Lab Zen Haiku Italia;
- Sacco, Lo haiku #1;
- Sacco, Lo haiku #2;
- Tauchner, Lo haikai vive di novità. Breve introduzione ai gendaihaiku;
- Cinisi, Ilfūryū. Una lettura di Kuki Shūzō.

Dopo svariati tentativi d’emergere con l’editoria tradizionale è diventato un fiero sostenitore del self publishing e dell’editoria digitale (Magazine Morello Edition) che gli ha permesso, a tutto tondo, di dar sfogo alla sua maestria creativa e di aiutare altri giovani artisti a far emergere la propria voce.
Ha raccolto la propria attività poetica nel volume “Per incontrarsi nel tempo”. Il meglio della sua produzione in prosa è esperibile ne “Il baule del migrante”: ampia opera poliedrica compo-sta da 29 racconti brevi, varie illustrazioni digitali e 3 volumi di poesie eteronime.







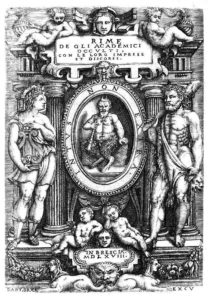
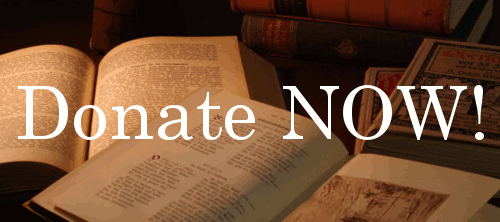 Sostieni "Il Sileno"
Sostieni "Il Sileno"