“Ognuno di noi presenta nei geni tracce di quello che c’era prima, dei popoli che con i loro usi e i loro costumi hanno abitato i territori dove oggi abbiamo costruito i nostri fabbricati cementiferi”
Le origini di San Giovanni in Fiore, capoluogo dell’Altopiano Silano, associate come è ben noto alla figura dell’abate di “spirito profetico dotato” (Dante Alighieri, Paradiso, Canto XII, vv. 140-141) Gioacchino da Fiore, che intorno al 1200 avrebbe scelto il centro montano, circondato da pini larici e ginestre, per dare vita alla sua Nazareth calabrese, in realtà, sembrerebbero più remote.
C’è stato un prima, un tempo molto lontano, forse anche mitico, difficile da ricostruire ma non da immaginare. A raccontalo con grande inventiva e originalità sono gli autori del libro Gnirivo – Oje me fricu sulu, Paolo Venturini e Maria Teresa Guzzo.
Appartenendo entrambi al mondo dell’arte, graphic designer e illustratore Venturini, attrice e regista teatrale la Guzzo, sarà stato sicuramente semplice utilizzare il loro estro creativo ai fini di una ironica ricostruzione del passato preistorico del paese. Parodia di un classico testo di storia, il libro è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali racconta l’ascesa e il declino delle varie popolazioni che immaginariamente avrebbero abitato il territorio silano.
Popoli dai nomi bizzarri, sintesi di vizi e virtù tipici dei sangiovannesi: non sono altro che nomignoli, la cui origine è sicuramente piuttosto arcaica, ancora oggi impiegati nel dialetto locale. Il primo popolo di cui veniamo a conoscenza sono i Ciotàli, rumorosi e litigiosi, il loro aspetto si caratterizzava per il cosiddetto vummone, bernoccolo in fronte che si sarebbero procurati durante le frequenti raccolte del finocchietto di timpa.
Monoteisti, adoravano la Frinnìcula. Adorazione religiosa che i sangiovannesi sembrerebbero aver conservato verso carni e frattaglie in generale, appunto la frinnìcula. Seguono i Pamozi, i quali si impossessano del territorio dopo il “Gran Cisìno”, una grande guerra che vide la loro ascesa e la sottomissione di Ciotafricàta (capo dei Ciotàli).
Poi fu la volta dei Ciambrielli, poi quella dei Pisafierri, dei Tantilli, dei Vantuopoli dei quali se ne descrive l’ego smisurato, e ancora i Cacummari, i Giriei, i Catillazzi fino a giungere ai Tignusi. Di ogni civiltà se ne descrivono la genealogia, le abitudini, la fede, l’abbigliamento, le abitazioni e persino la genialità. La loro arcaicità è spesso messa in discussione dalla loro straordinaria capacità di “anticipare i tempi”.
Accanto a riferimenti ad alcuni eventi storici realmente accaduti, come la discesa dei Visigoti in Italia, vi sono citazioni alla cultura Pop contemporanea: così Alarico I, condivide le pagine con Steve Jobs, i Beatles, gli Stones e la New age. Altrettanto divertente è il racconto dell’evoluzione comica del nome del paese, che presso le ultime civiltà era mutato da Fiore di Rosa, a Fiore di Ceci, a Fiore di Velluto, a Fiore di Limone, puntuale riferimento alla celeberrima e amatissima canzone Fiore di ceci, prodotto del folkmarket locale.
Il libro pubblicato nell’aprile del 2015, ha avuto numerose presentazioni sul territorio regionale, ed è stato, in quello stesso anno, oggetto di esame del corso di Demografia tenuto dal docente Pietro Iaquinta, del dipartimento di Economia e Statistica dell’Università della Calabria. Un libro di poco più di 100 pagine, il cui scopo principale è far ridere, una lettura disimpegnata ma che stimola la fantasia.

Di seguito l’intervista ai due autori, che ringrazio per la disponibilità e la puntualità nel rispondere, all’unisono, alle mie domande:
Com’è nata l’idea di scrivere un libro sugli antenati “immaginari” del popolo sangiovannese?
«Da tempo ci interrogavamo sull’origine di alcuni appellativi quali Ciotàle, Pamozio, Pantasima, Cacummaru etc, che appartengono alla tradizione Sangiovannese ed a quella Calabrese in generale. Ecco, noi abbiamo fatto un percorso alternativo, invece di chiedere ad un linguista l’origine di tali “nomi”, abbiamo dato loro una connotazione storica, riconducendoli ad alcuni popoli che abitavano la Sila nella preistoria. All’inizio pensavamo di ricavarne una sorta di opuscoletto da distribuire gli amici, poi ci siamo lasciati prendere la mano spinti anche dal nostro editore Pubblisfera, che ne aveva intuito le potenzialità, ed è diventato un vero e proprio libro».
Come si è svolta la vostra immaginifica indagine storico-filologica?
«Per quanto riguarda la ricerca storica, come spieghiamo nell’introduzione, è avvenuta attraverso uno scavo archeologico e la tradizione orale. Nello specifico dell’indagine filologica, questa non si è potuta compiere, perché noi siamo il testo zero, dopo di noi altri fantastorici potranno attingere a Gnirivo».
Suppongo che per ritrarre alcuni dei personaggi del libro vi siate ispirati a qualcuno di vostra conoscenza. è stato così oppure è una mia impressione?
«È una tua impressione. In realtà i personaggi si sono manifestati da soli senza che ci ispirassimo a nessuno, hanno scritto personalmente loro le parti che li riguardavano. Ma ognuno di noi, può specchiarsi in essi, perché molto rappresentativi».
A quale delle civiltà descritte pensate di essere prossimi discendenti?
Essendo noi un miscuglio di geni, che lottano per essere dominanti, ci si sente discendenti di qualche popolo in base alle giornate. Oggi un poco Ciambrielli e domani Sgualiciati totali, nella visione siamo sempre figli di Gnirivo sul filo del Noir».
“Gnirivo” avràun seguito?
«Sì, ha già un tanto atteso seguito che aspetta solo di essere inseguito».
Il “Rotalupo” della storia, come avete ben metaforicamente spiegato, cambia gli assetti sociali da secolo in secolo, anche se come diceva Machiavelli “tutti li tempi tornano, li uomini sono sempre li medesimi“. Avendo fantasticato sul trapassato remoto di San Giovanni in Fiore secondo voi, continuando a fantasticare, cosa ci aspetta? Quale futuro immaginate per il paese? Ci saranno ancora i personaggi di cui avete raccontato?
«Noi siamo già il futuro che i popoli del trapassato immaginavano. Il nostro presente è il futuro di Gnirivo. Siamo adesso un miscuglio di “razze”, con i personaggi del libro tutti presenti, che la natura ha rinchiuso in casa per evitare che facessimo ulteriori danni».
Maria Claudia Leone

Laureata al DAMS dell’Università della Calabria, con una tesi sul lavoro di indagine folklorica della cantautrice e artista cilena Violeta Parra. Attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze storiche della medesima università.







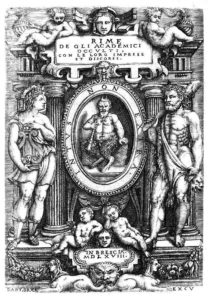
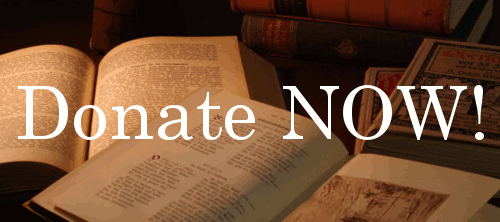 Sostieni "Il Sileno"
Sostieni "Il Sileno"